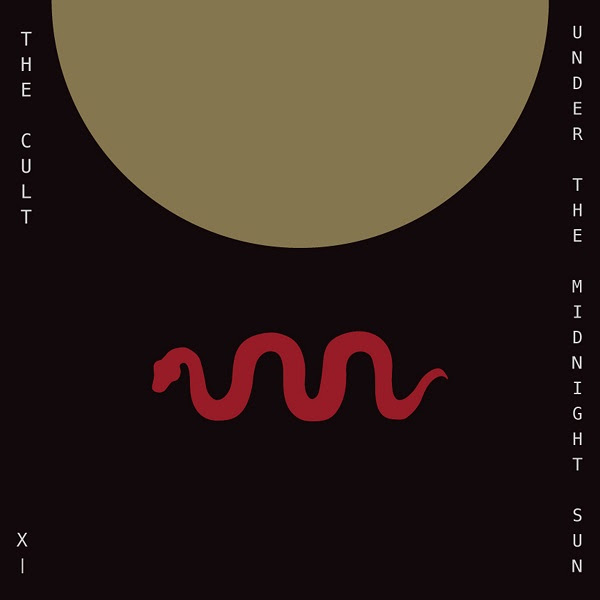Herbie Hancock: recensione del concerto del 13 luglio 2022, Roma
Scritto da Jimbo il 15 Luglio 2022
Come passa il tempo. Herbie Hencock: 82 anni e dire “e non sentirli” è assai poco. Ieri ci si è trovati davanti a nulla di meno di 5 maestri di musica che hanno onorato, ancora una volta, il rituale della creazione del miracolo sonoro.
Musica non più trattata da musica, ma da forma d’arte. Elevata nell’aspetto contenutistico ad autentica architettura di armonie e arrangiamenti. Elevata dal punto di vista espressivo, dall’esecuzione impeccabile. Elevata dal punto di vista emozionale, prendendo per mano l’ascoltatore e aprendo un mondo di pensieri, prima, e emozioni poi, che raramente si riescono a visitare.
Pace dei sensi e inevitabile sentimento di orgoglio per appartenere a una razza, quella umana, in grado di saper fare cose così dannatamente belle.
Potremmo parlare dei pezzi, della scaletta, dei volumi, dei suoni – una meraviglia: forse l’unico, ma proprio l’unico neo a volerlo trovare: la chitarra di Lionel Loueke in alcune sezioni sovrastata dal resto e qualche altra cosina per il basso.
Potremmo parlare di come le mani da enfant prodige siano sparite anche ieri sera, nel crescendo dell’assolo di Footprints al piano, riversando sugli ascoltatori un’autentica cascata di note liquide a una velocità strabiliante.
E invece vi parleremo di due momenti specifici.

Il primo momento del concerto di Herbie Hancock
Il Vocoder che si inceppa. La rivolta delle macchine. Lo strumento, è solo un’ipotesi, non dava segni di vita riuscendo a sincronizzarsi con il synth che usava Hancock. Guasto tecnico.
Herbie ha intrattenuto noi spettatori, ha scherzato, ha perfino finto di sculacciare il synth chiedendogli: “Perché mi fai questo?“. Poi con la coda dell’occhio, mentre la band – neanche a dirlo, un orologio di atomica precisione – continuava a tenere il tempo senza remore, guarda il pianoforte accanto.
Si ricorda che c’è un pianoforte. Lo abbiamo letto nei suoi occhi: “Perché no?“. Si è seduto.
Prima una nota, poi una frase, e poi musica. Così, creata al momento. Di una bellezza sublime, unica e irripetibile e, a meno che qualcuno non l’abbia registrata, potrà essere ricordata solo nella nostra memoria.
Creata per noi, nel frattempo, aspettando che le macchine sbrigassero le loro lungaggini e protocolli.
In estrema sintesi ciò che la musica dovrebbe fare: elevare lo spirito e consolare al bisogno, se qualche problema ci affligge. Noi ascoltandolo e lui ricordando che fino a che hai due mani e un pianoforte, alla fine davvero non hai bisogno di tanto altro.
In quel momento la “Rockstar” è svanita e c’era solo il Musicista.
La band si è rilassata. La Cavea è sparita. tutto è virato al nero e sembrava di vedere solo il Jazzista. Il band leader dentro qualche fumoso club di New York, con la sigaretta accesa sul posacenere, il bicchiere con un dito di quello buono e l’improvvisazione come unica rotta di vita. Solo uno dei tanti quintetti, che rischi di trovare un venerdì sera molto fortunato, uscito dal lavoro.
Sembrava solo una di quelle band che si esibisce davanti a poche persone seguendo il vecchio adagio, che il Bluesman è colui che suona una decina di note – e che note…- davanti a centinaia di persone, mentre il Jazzista è colui che suona centinaia di note davanti a una decina di persone.
Poi le macchine hanno fatto il loro lavoro.
Il maestro è ritornato alla tastiera e lo show è ricominciato. Uno show pazzesco che avremmo voluto non finisse mai.
Uno show che solo per quei 5 minuti di fuori-programma è valso comunque tutto il prezzo del biglietto. Cinque minuti che sono serviti da lezione. Una lezione che sancisce, semmai ce ne fosse stato ancora bisogno, che il mezzo non potrà mai vincere sul fine.
Lezione che oggi in troppi dimenticano, sfornando singoli a raffica, tutto mezzo e assai poco fine.
Il secondo momento
Il pezzo finale. 82 anni e non sentirli. Tastiera a tracolla. Un funky con una Chameleon uptempo, – forse, ma chi ci capiva più niente ormai – con un groove pazzesco e 5 uomini che sembravano 10.
Perso nell’esecuzione a un certo punto scorge un bimbo di circa 7 anni, con il cappello sulle ventitré che segue il ritmo e inizia a ballare come Michael Jackson, sparando pose da breaker, con tanto di spaccate.
Hancock lo vede e si dirige in quel settore del palco. Suona per lui e quando il bimbo smette, Hancock applaude. É troppo pure se hai pagato per il parterre. Tutti hanno mollato il proprio posto, tutti in piedi, tutti sotto il palco, tutti a ballare. E lui a 82 anni, tastiera a tracolla, ci ha pettinato tutti. La Rockstar era ritornata al culmine della sua grandezza.
Per concludere, Terennce Blanchard alla tromba ci ha tirato per aria e fatto planare senza soluzione di continuità; in ultima analisi, forse, l’unico in grado di distogliere l’attenzione da Hancock.
James Genus al basso non ha perso un colpo – va bene… forse un paio, ma non è davvero importante – e la divagazione in solitaria con la loop station ci ha spediti altrove.
Lionel Loueke alla chitarra, forse un po’ sacrificato dal muro sonoro del resto ma è quello che è uscito meno, complice anche un fraseggio molto concettuale che domandava più attenzione per essere fruibile.
Justin Tyson alla batteria è stato un treno lanciato in corsa. Forse un po’ più di Shuffle e un po’ meno Straight avrebbe donato un tocco più rotondo, ma la “pezza” era davvero imbarazzante.
Tutti bravi. No bravi. Eccellenti!
Ma se lo show era di Herbie Hancock, a 82 anni, la Rockstar, il Jazzista, il Musicista lo show lo ha fatto. Lo ha fatto alla grande.